
«Devo fare un annuncio. È una cosa importante. È scomparsa la poesia. Se qualcuno sa dove si trova, se ne ha notizie, è pregato di farsi vivo. Non ha segni particolari e questo non può che essere un problema, anche perché – e c’è da stare all’erta – girano impostori che si divertono alle sue spalle (alle nostre spalle). Solo una cosa mi sento di dire: non è che se uno si veste da Napoleone allora è Napoleone».
È un’autocitazione di una cosa che ho detto sotto la doccia. Sotto la doccia mi vengono delle idee che lì per lì mi sembrano geniali. Questa cosa, oltre ad entrare in conflitto col mio lato ecologista (quanti metri cubi d’acqua consumerei per scrivere un romanzo?), mi crea non pochi problemi, come ad esempio uscire sgocciolante dal bagno e precipitarmi al computer per scrivere. Per me la doccia è come per Superman la cabina telefonica, con una fondamentale differenza: se Clark Kent fosse Superman solo nella cabina, non sarebbe di grande utilità. Certo, potrebbe fare delle telefonate eroiche. Potrebbe comporre un numero e dire: «Attenzione signora, ha lasciato il gas aperto». Ma vai a spiegare a un macchinista che il ponte è crollato e che deve fermare il treno im-me-dia-ta-men-te! Ecco, una volta uscito dalla doccia sei fregato, hai perso quella sicurezza. Sei un essere come gli altri. E prendi pure freddo, lì in accappatoio, davanti al pc.
La poesia si è inflazionata. È qualche giorno che entro ed esco dalla doccia per venire a capo di questo pensiero. Una bistecca ben cucinata non è poetica, semmai è squisita. Se una donna dopo che avete fatto l’amore ti dice «Sei stato poetico», scappa, offenditi o vedi di impegnarti di più. Se qualcuno ti vuol far credere che un abbraccio è poetico, tu ridigli pure in faccia.
Abbiamo aggettivizzato la poesia. Vediamo un paesaggio innevato o un tramonto sul mare e lo definiamo poetico, fraintendendo evidentemente il fascino con la poesia. Non è un problema marginale. Se la poesia è ovunque non è da nessuna parte. O per dirla con una legge economica: la moneta cattiva scaccia quella buona.
Qualcuno potrebbe scrollare le spalle, pensare che in un momento di crisi, in un momento dove gli imprenditori si impiccano ogni giorno, non è il caso di parlare di poesia. Ma è proprio questo il punto.
Solo in un giorno la Grecia ha perso 800 milioni di euro. La gente si è silenziosamente messa in fila ai bancomat e ha prelevato 500 € alla volta. Hanno paura che torni la dracma e che il loro denaro perda, nel giro di una notte, dal 30% al 60% in potere d’acquisto. Non ci sono state scene di panico. Inserisci la tessera, inserisci il pin e prelevi un po’ oggi, un po’ domani. La tecnologia è fredda. Il bancomat non è nemmeno stato informato della congiuntura economica sfavorevole.
La nostra risposta alla crisi è il tecnicismo. Abbiamo introdotto governi tecnici, soluzioni tecniche, riforme tecniche. Ci piace da morire la tecnica. Siamo profondamente convinti che si debba fare qualcosa di concreto: ad X corrisponderà Y e quindi, finalmente, Z. Ci piace il governo del fare. E ci piace freddo. A qualcuno piace freddo.
Entro ed esco dalla doccia e penso che la poesia possa aiutarci. Provo ad azzardare: durante le crisi la domanda di poesia sale. Non sto parlando prettamente di mercato (la poesia costituisce un misero 5% del mercato librario), ma di esigenza intima. È un antigelo. E l’offerta a ben vedere ci sarebbe pure. Ci sono persino poeti vivi. Addirittura poeti italiani e vivi. Gabriele Frasca, Elisa Biagini, Milo De Angelis, Maria Grazia Calandrone, Andrea Inglese, Valerio Magrelli, Patrizia Cavalli. Ed è un elenco orrendamente incompleto, ovviamente.
Abbiamo bisogno di poesia, ma non sappiamo più riconoscerla.
Le azioni non sono poetiche, è l’interpretazione che ne facciamo, sono le parole che usiamo in un certo modo e non in un altro che sono, possono essere, poetiche. E non è detto che la poesia ti faccia piangere. La cipolla, se non la metti in freezer, ti fa piangere. Sempre. La poesia no.
La poesia non sta nelle cose, sta nelle relazioni. Riguarda i nostri filtri creativi, quel particolare modo con cui interpretiamo il mondo. Meglio: la poesia sta nel modo che abbiamo di spiegare le relazioni. È tradurre le relazioni in linguaggio verbale. Impresa fisiologicamente fallimentare: alchimia impossibile.
La poesia è forma. È sempre incarnata nel linguaggio, altrimenti non è nulla. E la forma in poesia è metrica. Ovvero, se vogliamo stare al dizionario, «il complesso delle leggi che regolano la composizione dei versi». Non si riduce tutto alla metrica, ma la metrica è condizione fondamentale della poesia.
Per dirla con le parole di Gabriella Sica, poetessa e docente di Letteratura italiana all’Università La Sapienza, «la poesia esiste, cioè ex-siste, quando si separa dalla morte, rinuncia alla confusione e accetta, con pietas materna, la caducità dolorosa della vita, ma anche una lingua» (Scrivere in versi, Il Saggiatore, 2003, pp. 15-16).
La poesia esiste solo quando si incarna nella lingua. Solo così rinuncia alla morte, ovvero si fa morente.
Dobbiamo accettare che anche se fuori dalla doccia siamo comuni mortali questo non è un difetto. Superman non potrà mai essere un bravo poeta. E nemmeno potrà fare molto per salvarci dalla crisi. Ci serve un atto eroico ben più arduo che fermare un treno con una mano: accettare la complessità della vita, la fitta trama di relazioni da cui è composta, il fatto che non c’è nessuna scelta X, Z, Y che possa tirarci magicamente fuori dai guai.
Ci serve un antigelo. La poesia ci serve.
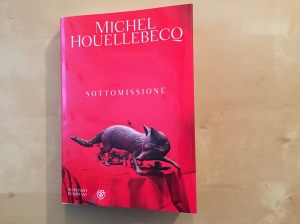

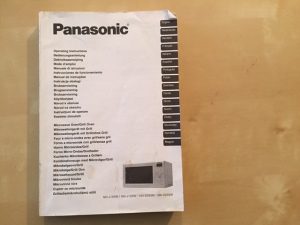
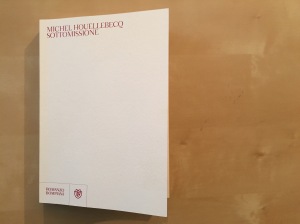






 Sono andato a comprare l’ultimo libro di José Saramago – Caino, Feltrinelli Editore – e mi hanno regalato uno dei quei libercoli promozionali che fanno da anteprima alle nuove uscite. Suddetto libercolo sta alla letteratura come il trailer sta al cinema e siccome adoro i trailer non sono riuscito a dire di no. Non ho detto di no, nonostante tale libercolo si intitolasse: La caduta dei giganti. Autore: Ken Follet. Saramago contro Ken Follet, il saggio contro il robottone, Gandalf contro il mostro.
Sono andato a comprare l’ultimo libro di José Saramago – Caino, Feltrinelli Editore – e mi hanno regalato uno dei quei libercoli promozionali che fanno da anteprima alle nuove uscite. Suddetto libercolo sta alla letteratura come il trailer sta al cinema e siccome adoro i trailer non sono riuscito a dire di no. Non ho detto di no, nonostante tale libercolo si intitolasse: La caduta dei giganti. Autore: Ken Follet. Saramago contro Ken Follet, il saggio contro il robottone, Gandalf contro il mostro. A pagina 126 ho deciso di interrompere la lettura di Delitto e castigo. Io e i russi non andiamo d’accordo evidentemente. Pure con Anna Karenina è andata così. È più forte di me, inizio con i migliori intenti, rimango affascinato dagli incipit, ma poi mi perdo. Quando Raskolnikov fa fuori ad accettate quella vecchia bagascia dell’usuraia ho pensato di trovarmi in un film dei fratelli Cohen. Poi a pagina 126 mi sono rotto le scatole. Ho chiuso il libro e mi sono addormentato. Intendiamoci, non incolpo né Tolstoj, né Dostoevski, né il Cremlino: la colpa deve essere mia. Ciò non toglie che una qualche ragione ci sarà. Così mentre dormo rimugino sulla mia sconfitta.
A pagina 126 ho deciso di interrompere la lettura di Delitto e castigo. Io e i russi non andiamo d’accordo evidentemente. Pure con Anna Karenina è andata così. È più forte di me, inizio con i migliori intenti, rimango affascinato dagli incipit, ma poi mi perdo. Quando Raskolnikov fa fuori ad accettate quella vecchia bagascia dell’usuraia ho pensato di trovarmi in un film dei fratelli Cohen. Poi a pagina 126 mi sono rotto le scatole. Ho chiuso il libro e mi sono addormentato. Intendiamoci, non incolpo né Tolstoj, né Dostoevski, né il Cremlino: la colpa deve essere mia. Ciò non toglie che una qualche ragione ci sarà. Così mentre dormo rimugino sulla mia sconfitta.